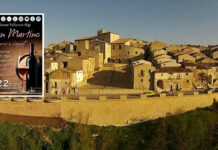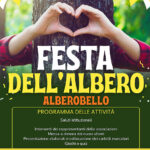Come annunciato mercoledì 29 ottobre alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara inoccasione dei 50 anni del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, tornano nella settimana dal 24 al 29 novembre le “Giornate FAI per le scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che daquattordici annila Fondazione organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. La manifestazione fa parte del programma nazionale“FAI per la Scuola”, un piano ricco e articolato che ben esprime la vocazione del FAI all’educazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura del patrimonio culturale italiano, proprio a partire dalle giovani generazioni.
Per la realizzazione di questo programma, il FAI operain collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa, che si fondasui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella curadell’ambiente che ci circonda.Il FAI opera da cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativasecondo le direttive delle nuove linee guida ministeriali.
Protagonisti delle Giornate saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al FAI, vivendo un coinvolgimento diretto nella valorizzazione del proprio territorio come parte attiva della comunità, e assurgendo a esempio per molti giovani in uno scambio educativo tra pari. Le Delegazioni di migliaia di volontari della Fondazione, diffusi e attivi in tutte le regioni, apriranno infatti oltre duecento luoghi speciali che saranno visitati da studenti iscritti al FAI con la propria classe. Le classi “Amiche FAI” saranno accolte da migliaia di ragazzi e condotte alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio, che ne racconteranno la storia, ne sveleranno i capolavori e i particolari curiosi, proponendo ai loro pari un’esperienza memorabile, che li motiverà a farsi cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell’Italia.
Anche quest’anno i beni apertiin tutta Italiasono di diverse tipologie e offrono ricchi spunti didattici per le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano nelle attività di scoperta del territorio e del patrimonio locale la visita al Castello di Arco (TN), gioiello medievale che svelerà agli studenti ambienti solitamente chiusi, ai Sassi di Matera, dove gli studenti approfondiranno in un percorso tematico l’antica economia della cera, fino al quartiere Maria Ausiliatrice di Alcamo (TP), protagonista di un progetto di rigenerazione urbana attraverso la street art. Altri beni sono legati all’educazione civica e alla memoria, come il Museo Falcone-Borsellino di Palermo, il percorso nella Forlì colpita nel 1944, o il Palazzo Vivante di Trieste, testimone della storia asburgica e del primo dopoguerra. Alcuni luoghi offrono, poi, spunti di educazione ambientale e scientifica, come la scuola di Balmuccia, presidio contro lo spopolamento ed esempio di sostenibilità in alta Valsesia, l’Istituto Zooprofilattico di Portici, impegnato nella tutela ambientale e animale, e il Museo della Scuola di Bolzano, che racconta l’evoluzione dell’istruzione nelle diverse culture locali.
Le Giornate FAI per le scuole si confermano un’esperienza formativa di grande efficacia e soddisfazione per tutti: unprogetto che trasforma, ispira per il futuro, rende protagonisti e diffonde passione per la conoscenza, da cui scaturisce il desiderio di proteggere il patrimonio di storia, arte e natura italiano per sempre e per tutti, come è descritto nella missione del FAI.
L’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” e la partecipazione alle Giornate FAI per le scuole sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica FAI, che quest’anno si arricchisce anche di un contenuto in più:una speciale piattaforma e-learning con video esclusivi che approfondisce le professioni dei Beni Culturali, nell’ottica delle attività di orientamento in linea con le recenti indicazioni ministeriali.
“In tanti anni di esperienza sussidiaria a quella del mondo della scuola il FAI ha imparato che l’oggetto della sua missione non è affatto estraneo al mondo dei giovani e che, anzi!, se coinvolti con la chiave giusta essi si appassionano alla realtà della storia, dell’arte e del paesaggio storico e naturale con una facilità e un vigore sorprendenti, scoprendo quanto sia più gratificante ed emozionante l’esperienza concreta rispetto a quella virtuale.” ha dichiarato Marco Magnifico – Presidente FAI
La quattordicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.
Si ringraziano, inoltre, Regione Campania, Provincia autonoma di Trento e Fondazione CARICAL per i contributi concessi. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.
Il progetto sarà sostenuto anche quest’anno da AGN ENERGIA, da dieci edizioni sponsor principale dell’evento, sempre sensibile al rispetto per l’ambiente e alle iniziative che coinvolgono la scuola. Novità per l’anno scolastico 2025-26 è la creazione del percorso didattico ‘I Detective dell’Energia’, per approfondire in classe il tema del consumo e del risparmio energetico attraverso video e attività coinvolgenti differenziate per fasce d’età.Al termine della formazione, sarà possibile partecipare alla nuova edizione del contest online “#LATUAIDEAGREEN”, che invita gli studenti a scegliere quale, tra tre opere di street art dedicate al tema e finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza, vorrebbero vedere realizzata in una città italiana. AGN ENERGIA, inoltre, destinerà un contributo alla manutenzione annuale del Monastero di Torba,Bene FAIa pochi chilometri da Varese, un complesso monumentale longobardo, oggi parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Questo sostegno sarà dedicato alla scuola del vincitore del contest.
TRA I BENI APERTI IN PUGLIA
CANOSA DI PUGLIA (BT)
Ipogeo di Cerbero
L’Ipogeo del Cerbero è un monumento funerario dauno del III secolo a.C. e scoperto a Canosa di Puglia nel 1972. È composto da tombe a camera scavate nel banco calcarenitico o argilloso e risalenti a un’epoca compresa tra il IV e il II sec. a.C., periodo durante il quale Canosa – come tutta la Daunia – assimilò le influenze culturali e rituali provenienti dal mondo greco. Deriva il su nome da un affresco che rappresenta il mitologico cane a tre teste Cerbero, a guardia del passaggio del defunto verso l’oltretomba. Attraverso un dromos (corridoio) in discesa, si scende a un atrio e a camere sepolcrali che dovettero vantare un ricco corredo funerario, di cui oggi non rimane traccia. Anche la parte superiore delle pareti è andata perduta a causa dei movimenti dei macchinari da cantiere. La cella anteriore a destra si contraddistingue per i resti di una pittura parietale che raffigura una “deductio ad inferos”, con Hermes Psychopompos e un palafreniere che scortano il defunto fino all’ingresso nell’Ade, presieduto dal leggendario cane a tre teste Cerbero. Il dipinto è stato esaltato in un videomapping elaborato dallo Studio Glowarp nel 2018.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS Fermi-Einaudi di Canosa di Puglia (BT)
MARGHERITA DI SAVOIA (BT)
Le saline
Il contesto in cui sorgono le Saline di Margherita di Savoia è quello della fascia costiera affacciata sull’Adriatico meridionale a Sud del Golfo di Manfredonia.Territorio dell’antica Daunia, ricco di corsi d’acqua brevi e a regime irregolare e caratterizzato da uno sbarramento costiero, l’attuale Salina di Margherita di Savoia è il risultato di un lunghissimo processo di trasformazione dell’antico lago di Salpi, in seguito ai numerosi tentativi di bonificare un’area periodicamente soggetta a impaludamenti e a conseguente diffusione di infezioni malariche. La presenza del sale come formazione spontanea è qui attestata sin dalla Preistoria. In età romana Strabone o Vitruvio confermano l’esistenza di città come Salapia o Salinis che portano nel nome stesso la prova dell’importanza che la produzione del sale aveva per questa terra. Ma sarà solo a partire dal ‘700 che con Vanvitelli si darà inizio al primo grande progetto di bonifica dell’area, finalizzata alla costruzione di vasche per la produzione di sale.Le Saline di Margherita di Savoia, dal 1979 area protetta dalla Convenzione di Ramsar, hanno un’estensione di circa 4.000 ettari e ricadono nei territori di ben cinque comuni: Margherita di Savoia, Trinitapoli, Cerignola, Zapponet, Manfredonia. Attraverso le idrovore di Foce Carmosina e con un sistema di canali interni, l’acqua del mare viene immessa nelle vasche evaporanti e nelle vasche salanti dove, a seguito di un viaggio lungo chilometri, avviene la definitiva formazione dei cristalli di sale. La vasta area ospita centinaia di specie animali e vegetali, in particolare il fenicottero rosa e la salicornia.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Aldo Moro e dell’Istituto Comprensivo Statale Pascoli-Giovanni XXIII di Margherita di Savoia (BT)
LECCE
FAI…la storia: Chiesa di Sant’Angelo
La Chiesa di S. Angelo, conosciuta anche col nome di S. Maria di Costantinopoli, è una delle prime chiese edificate nella città di Lecce, la cui costruzione risale al 1061. A causa di pessime condizioni strutturali la chiesa fu ricostruita nel 1663 per volere degli agostiniani su progetto di Zimbalo, il famoso architetto del barocco leccese, il cui gusto si legge chiaramente già nelle decorazioni della facciata: il fregio è arricchito da una sequenza fitta di figure come leoni, aquile e putti, ognuno dei quali regge una lettera dell’epigrafe dedicatoria in latino. Anche il portale d’ingresso è ornato da un’elegante decorazione vegetale e figurativa, che reca al centro della lunetta la statua della Madonna col Bambino. L’interno, a navata unica con pianta a croce latina, presenta pareti laterali scandite da lesene scanalate, ognuna sormontata da capitelli diversi per forma e decoro. Gli altari barocchi, attribuiti in parte allo stesso Zimbalo, sono riccamente decorati con motivi scultorei, dipinti e statue in pietra e cartapesta.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Lecce
MORCIANO DI LEUCA (LE)
Complesso di Leuca Piccola
Frazione di 952 abitanti del comune di Morciano di Leuca, Barbarano del Capo è un territorio roccioso e carsico nella vallata fra Serra Falitte e Serra di Montesardo, a 130 metri sul livello del mare. Il nome dell’abitato deriva probabilmente da “barbari” e dalla distruzione della città di Vereto da parte dei saraceni nel IX secolo. Con l’arrivo dei Normanni verso la fine del XII secolo, il re Tancredi d’Altavilla donò il feudo a Lancellotto Capece, la cui famiglia ha lasciato una rilevante impronta della sua presenza con la costruzione di una torre fortificata. Costruito tra il 1685 e il 1709 dal barone Annibale Francesco Capace, il Santuario di Santa Maria di Leuca del Belvedere è situato lungo il tragitto che i pellegrini percorrevano per giungere al Santuario De FinibusTerrae di Santa Maria di Leuca. Conosciuto anche con il nome di Leuca Piccola, venne concepito come luogo di preghiera e di ristoro in quanto dotato non solo di ambienti religiosi ma anche di locali destinati al riposo e al ristoro dei pellegrini e degli animali. I pellegrini che vi giungevano riposavano durante la notte nei grandi sotterranei, appositamente scavati, per poi ripartire alla volta di Leuca alle prime luci dell’alba. La chiesa è un importante esempio di architettura rinascimentale ed è preceduta da un pronao a grandi arcate addossato alla facciata. L’interno è arricchito da affreschi sei-settecenteschi raffiguranti San Lazzaro, Santa Lucia, Sant’Oronzo, Santa Barbara, Santa Marina, San Francesco da Paola, San Pasquale Baylon, San Gennaro e San Leonardo. Pregevole è la volta affrescata con le figure dei quattro evangelisti uniti dalla sigla JHS scolpita sulla chiave di volta.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS G. Salvemini di Alessano (LE)
PARABITA (LE)
Parco Comunale Aldo Moro e Monumento ai Caduti di Guerra
Vera e propria “porta di accesso” verde per chi arriva in treno a Parabita, il Parco Comunale intitolato ad Aldo Moro conserva al suo interno il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. L’intitolazione del parco all’onorevole democristiano vittima del terrorismo, conferisce a questa area un profondo valore simbolico legato alla memoria storica, ai principi democratici e al sacrificio civile. Il Monumento ai caduti, del tipo a obelisco o stele, era originariamente arricchito da una statua in bronzo intitolata “Allegoria della Patria” o “La Parabita”. Il suo aspetto è cambiato drasticamente nel corso del tempo a causa degli eventi bellici; mantiene la sua funzione commemorativa con la presenza delle lapidi con i nomi dei Caduti e funge da punto focale per commemorazioni civili e militari. Il recente intervento di riqualificazione del 2023, parte integrante del più ampio progetto “Città Giardino”, ha reso il parco Aldo Moro un luminoso esempio di biodiversità e un vero polmone verde cittadino. I lavori hanno previsto l’eliminazione delle piante malate e la loro sostituzione con nuove essenze perfettamente adattate alle caratteristiche pedo-climatiche del territorio. Elemento distintivo dell’intervento è stata la realizzazione di un prato all’inglese e la messa a dimora di circa 700 rose paesaggistiche della cultivar Sevillana, in grado di offrire una spettacolare fioritura continua da maggio a dicembre. A ciò si aggiunge la piantumazione di circa 28 specie tra alberi e arbusti. Riconosciuto tra i parchi più belli di Puglia, quello di Parabita è oggi considerato un modello esemplare di riqualificazione urbana.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC di Parabita (LE)
BARI
Ateneo Università degli Studi di Bari Aldo Moro
L’Università degli Studi di Bari si trova nel cuore del quartiere murattiano, caratterizzato da strade regolari e isolati realizzati rigorosamente a scacchiera. L’ateneo venne istituito con Decreto 9 ottobre 1924 sulle fondamenta delle antiche Scuole Universitarie di Farmacia e di Notariato, attivate subito dopo l’Unità d’Italia in sostituzione dell’antico “Reale Liceo delle Puglie”. Nel gennaio 1925 fu istituita la Facoltà di Medicina e Chirurgia, che incorpora la preesistente Scuola per Ostetriche, e venne trasformata in Facoltà la Scuola di Farmacia. Successivamente a queste si aggiunsero le Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Commercio, nata dalla regia scuola superiore di commercio fondata nel 1882, e di Agraria. Dal 1944 in poi arriveranno le Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Ingegneria, Magistero, Medicina Veterinaria, Lingue e Lettere Straniere.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco e del Liceo Gaetano Salvemini di Bari
CONVERSANO (BA)
Monastero di San Francesco e la sua evoluzione
Piazza XX Settembre a Conversano è un luogo capace di raccontare una storia stratificata nel corso di 2500 anni, dove si incontrano il quartiere di espansione tardo medievale, quello rinascimentale con il nucleo più antico che ha mantenuto la sua forma urbis fino XIII secolo. Tra ‘800 e ‘900 i fronti degli edifici furono ridisegnati in forme neoclassiche definendo l’aspetto attuale della piazza. Su di essa affaccia la chiesa di San Francesco, realizzata nel 1289, come attestato da una epigrafe e rifatta in forme tardo barocche nel 1695. L’annesso convento duecentesco, oggi sede del Comune, fu trasformato a fine ‘800 dall’architetto Sante Simone, con un progetto di marcata impronta neoclassica. Sul fronte opposto, una balconata, anch’essa di gusto neoclassico, progettata dall’ingegnere Oronzio Gassi, si addossa alle antiche mura della città. Un altro elemento significativo della piazza è la Porta della Gabella, realizzata da Gualtieri IV di Brienne nel 1338, come riporta un’iscrizione sul fornice ogivale della porta. La torre civica, con orologio e campana che segna le ore, fa da fondale al corso che porta al monastero dei Santi Medici. A destra della torre un prospetto neoromanico con due bifore è anch’esso opera dell’architetto Sante Simone, mentre nel margine occidentale della piazza, in posizione antistante la torre civica, sorgeva la Porta di San Francesco che si apriva nel tratto di mura tardo medievali attorno a Casalvecchio e che dal ‘500 divenne l’accesso al quartiere di Casalnuovo.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceronidel Liceo Simone-Morea e del Liceo San Benedetto di Conversano (BA)
ALTAMURA (BA)
Chiesa di San Nicola dei Greci e Chiesa di San Biagio
Le due chiese si trovano nel centro della città lungo la strada centrale Corso Federico II di Svevia. San Nicola dei Greci, eretta per volere di Federico II di Svevia nel 1232 quando in città si iniziava anche la costruzione della cattedrale, fu realizzata in stile romanico per la locale comunità bizantina di rito greco-ortodosso a opera di presbiteri greci. Dedicata a san Nicola di Mira, fu officiata con rito greco fino al 1601, quando venne riadattata al rito latino e modificata l’iconostasi interna. Sarà successivamente ristrutturata nella seconda metà del XVI secolo. Impostata su un basamento a bugne, la facciata richiama alcuni elementi gotici, come il profilo a capanna con rosone centrale e il portale, un protiro su mensole a terminazione cuspidata, con tre fasce di decorazione scolpita. I rilievi delle fasce laterali e dell’architrave narrano le storie dell’Antico e del Nuovo Testamento. In centro alla cuspide campeggia la Trinità, circondata da angeli e santi, mentre sulla fascia verticale sinistra viene riprodotta l’immagine del Paradiso terrestre e la creazione di Adamo ed Eva. La chiesa di San Biagio fu invece edificata nel 1628 sui resti di un “antico ipogeo”, ed è stata restaurata nel 1742. È immediatamente riconoscibile da un grande affresco di oltre cinque metri di altezza situato sulla facciata e raffigurante San Cristoforo. Al di sopra del portale di ingresso sono visibili in alto una statua di San Biagio, e sulla destra un campanile. Dalla parte opposta è invece visibile un rosone cieco che si affaccia direttamente su corso Federico II.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Federico II di Svezia; della Scuola Secondaria di Primo Grado Padre Pio e della Scuola secondaria di Primo Grado Tommaso Fiore di Altamura (BA)
FOGGIA
Chiesa delle Croci
Il padre cappuccino Antonio da Olivadi, giunto a Foggia alla fine del Seicento, trovò una città piegata dalla siccità e si adoperò per dare speranza e fede alla gente. Dopo una predicazione, cominciò a piovere e i raccolti furono salvi. Decise quindi di piantare sette croci, su cinque delle quali furono costruite altrettante cappelle. In seguito furono edificati un monumentale arco trionfale e la chiesa barocca, costruita a partire dal 1693 e aperta al culto nel 1879. L’imponente portale è costituito da una parte inferiore divisa da quattro lesene, che inquadrano due nicchie vuote. Sopra le nicchie vi sono due riquadri con gli elementi della crocifissione: chiodi, corona di spine, martello e tenaglia. Al centro dell’arco si trova una colomba bianca, mentre ai due lati sono effigiati il sole e la luna antropomorfi che rappresentano l’umanità di Cristo. Attraversato l’arco, s’incontrano le cinque cappelle. L’esterno della chiesa è assai povero: una struttura a scatola, ai lati della quale furono aggiunti due corpi laterali, mentre l’interno è a una sola navata, con due cappelle laterali e il soffitto decorato con stucchi settecenteschi. Sulla volta campeggia una tela raffigurante la Salita al Calvario attribuita alla scuola napoletana. Sotto la chiesa è situata una piccola cripta chiamata Terra Santa, probabilmente sede di riunioni segrete durante il Risorgimento. Sul pavimento si apre una botola coperta da una lastra tombale con un’iscrizione in latino che indica la cripta in cui sono conservati i resti dei confratelli della Congregazione di Monte Calvario, che faceva capo alla chiesa. Intorno al complesso si è formato uno dei primi nuclei cittadini chiamato Borgo Croci. Inoltre, la Chiesa è l’unico Monumento Nazionale di Foggia.
Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Lanza di Foggia